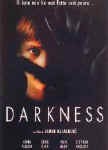Recensione n.1
Regista teatrale di successo (la stampa ha dato ampio risalto alle nudita’ di Nicole Kidman in “The blue room”), Sam Mendes e’
passato al cinema ottenendo una vera e propria consacrazione: pioggia di Oscar e folle oceaniche di spettatori per il sopravvalutato “American Beauty”. Alla non facile prova dell’opera seconda, le aspettative non restano deluse, nonostante qualche riserva.
“Road to perdition” si prenota gia’ come sicuro candidato alla prossima edizione degli Oscar. Eh si’, perche’ e’ il classico filmone hollywoodiano costruito con competenza e innegabile talento. La storia unisce il racconto di formazione con le vendette mafiose nella Chicago degli anni trenta, quella popolata solo da gangster e dark lady (che qui pero’ sono assenti). La sceneggiatura e’ di quelle ad orologeria, che al ventottesimo minuto prevedono un colpo di scena e rendono circolare il racconto. Si sfilaccia un po’ nella parte finale, con qualche ridondanza di troppo, ma e’ supportata da una regia davvero strepitosa. Sam Mendes trasforma le scene piu’ prevedibili in una gioia per gli occhi, con punti di vista interessanti ed efficaci soluzioni visive di ispirazione quasi pittorica. Si percepisce un’aria da primo della classe al banco di prova, ma il regista riesce a dosare con equilibrio il talento per la messa in scena con la forza del racconto.
Tom Hanks lavora di sottrazione e riesce comunque a comunicare lo spessore del suo personaggio. Paul Newman trova finalmente modo di risfoderare il suo carisma e si fa notare Daniel Craig per la maschera da clown del suo personaggio, sempre sorridente ma lucidamente folle. Jude Law conferma le sue doti istrioniche, anche se il suo interessante personaggio rischia di essere un po’ sopra le righe, quasi ridotto a stereotipo nel finale. Tra le scene indimenticabili, la sparatoria muta sotto la pioggia, con il solo commento musicale di Thomas Newman che la trasforma in una sorta di tragico balletto. Peccato per la conclusione esageratamente hollywoodiana, prevedibile e didascalica, che ancora una volta Sam Mendes riesce a riscattare (ma non a salvare) con la sua abilita’ registica.
Cinema di impianto tradizionale, sicuramente un po’ ruffiano nelle scelte narrative, ma solido e ben fatto. Meglio sicuramente della tutto sommato scontata indagine sociale di “American beauty”.
Luca Baroncini
Recensione n.2
Se la firma in calce a RTP non fosse di Sam Mendes, consiglierei a chiunque di vederselo in VHS e spendere meglio i 7 Euro. Ma visto che Mendes, almeno quanto a bellezza visiva, tiene fede a quanto mostrato con American Beauty in termini di gusto estetico, ammetto che il grande schermo è da preferire, sempre se si è disposti ad ingurgitare una storia vista e rivista e che più scontata e telefonata non si può, un vero festival dei luoghi comuni sul tema e corredata da una vasta maggioranza di parti in cui gli stessi dialoghi sono persino imbarazzanti.
Strano, perchè il film di esordio di Mendes era invece quanto di più anti-convenzionale ed anti-americano si fosse visto da anni. La formula di RTP è invece scontata e prevedibile più di un Bond-film, con la differenza che nei film di 007 almeno non ci sono bambini di mezzo. E si sa, da sempre ad Hollywood con poche eccezioni, dove c’è un bambino c’è una palla di film. Si salvano l’ottima interpretazione di Hanks, un buon Law, qualche scambio ben giocato sul piano del ritmo e della misura tra il padre ed il bambino, almeno due sequenze da antologia (quelle delle rapine alle banche e la sparatoria nell’hotel) e quello stile visivo-narrativo davvero impagabile di Mendes, un maestro nel disegnare inquadrature e fotografie. Un’America livida e grigia, come la storia, filtrata da fotografie dove il sole non c’è quasi mai, nemmeno quando c’è davvero il sole.
Guglielmo Pizzinelli
Recensione n.3
Nella folla di uomini grigi, cappello e cappotto, che scorrono veloci le strade di citta’ guardando fisso avanti a se’, c’e’ solo una persona che guarda in alto, incantata: e’ un bambino, un bambino che sta vivendo un’avventura talmente inquietante da fargli dimenticare la tragedia che l’ha causata.
Mendes racconta un paese che diventa grande, ma non migliore, visto con gli occhi di chi vive immerso in valori morali quantomeno atipici. Il contrasto tra citta’ e campagna, tra famiglia e lavoro, tra dovere e affetti, tra giusto e sbagliato ha una perfetta resa cromatica nei grigi che dominano la scena, il grigio degli uomini, dei padri, dei soldi, illuminato piu’ dal sangue che dal sole.
“Ci sono solo assassini in questa stanza”, ma Mendes si concentra sulle sfumature del male, assolvendo chi, come Mike Sullivan, rimane capace di amore, correttezza e lealta’, in contrasto con l’amoralita’ di chi trova tutto “fottutamente ridicolo”. Road to Perdition e’ denso di nostalgia e di richiami, un invito a tornare dentro di se’, ritrovare cio’ che ci rende umani, dimenticare quei corpi illuminati da un lampione che cadono, cadono, cadono…
Un film godibile da diversi punti di vista, a partire dalla perfetta ricostruzione dell’america anni ’30, con una criminalita’ dove per una volta sono protagonisti gli americani, con gli italiani sullo sfondo; anche per questo forse piu’ capace del solito (al cinema) di tollerare un contabile gay e un killer quantomeno affascinante nella sua perversione voyeuristica. Fotografare un morente che hai appena ucciso: nella strada per Perdition c’e’ pero’ ancora posto per un bambino, un bambino che, come tutti, amava suo padre nonostante tutto.
Mafe
Recensione n.4
Michael O’Sullivan (Tom Hanks) conduce disinvoltamente una doppia vita: da un lato è un killer spietato al servizio del boss John Rooney (Paul Newman), dall’altro è un amorevole benché severo padre di famiglia, molto innamorato della fedele moglie. Rooney per lui è anche una sorta di padre, che lo ha adottato quando era bambino e che si è sempre occupato di lui. Da cui l’invidia e la gelosia del figlio naturale Connor Rooney che mal sopporta il profondo affetto che lega i due. Tutto sembra andare per il meglio (si fa per dire), fino a quando il figlio maggiore di Michael assiste incautamente ad una strage su commissione. Connor si occuperà personalmente di eliminare la moglie e l’altro figliolo di O’Sullivan. Da questo momento in poi, il film verte tutto sul desiderio di vendetta di Michael che, in viaggio con l’unico superstite della sua famiglia, cercherà in tutti i modi di farsi giustizia da solo.
In apparenza l’ennesimo film di gangster, che assomiglia ad un fumetto western. In realtà, una doppia storia psicoanalitica che illumina sulla verità dei rapporti familiari. Ho già accennato alla rivalità fra Michael e Connor, rivalità che si rispecchia nel rapporto fra i due figlioli di Michael. Anch’essi antagonisti in quanto il primogenito è convinto di essere il meno amato dei due. Le sei settimane che trascorrerà in fuga gli offriranno l’occasione di chiarire il rapporto con il padre, di comprendere le ragioni alla base della sua solo apparente freddezza e di comunicargli la profondità del suo amore. Il lieto fine è più psicologico che altro. Devo ammettere che il film non mi è piaciuto e, in più di un’occasione, mi ha addirittura annoiato. Tom Hanks, di cui avevo molto apprezzato l’interpretazione in “Castaway”, è come ingessato in un’unica espressione che dovrebbe rendere la spietatezza del killer. Paul Newman è sfuocato, forse l’età, ha perso l’abituale smalto e non è all’altezza del ruolo di moderno “Re Lear”. La pellicola manca di ritmo, la storia già scontata si snoda con un’eccessiva lentezza che è del tutto ingiustificata. Salverei solo qualche scena: la vendetta consumata nel bagno dell’hotel, la mitragliata sotto la pioggia battente, il killer-maniaco che immortala le proprie bravate. Ma in troppe occasioni il regista cerca di commuovere il pubblico, di strappargli qualche lacrimuccia di commozione. Nessuno direbbe che è il Sam Mendes che ha girato il cinico e amaro “American Beauty”. Furbo e prevedibile, consolatorio e rappacificante, un film di buoni sentimenti, adatto alla visione familiare in occasione del Natale.
Mariella Minna
Recensione n.5
In un bel affresco dell’America anni ’30 colorata da una patina grigio-oro, si sviluppa l’avventura del gangster Michael O’Sullivan e di suo figlio. Storia di un viaggio, storia di una disperata vendetta, ma anche storia del rapporto tra un padre e suo figlio.
Apprezzabili silenzi fioccano in una godibile sceneggiatura che lascia molto spazio alle immagini, mentre un buon Tom Hanks veste gli insoliti panni di un duro vecchio stampo, di poche parole, “onesto” uomo d’onore che non perdona l’offesa, tanto più se questa odora di morte.
Dopo i fastidiosi latrati venduti per “dialetto siciliano” di Aldo, Giovanni e Giacomo, assistere ad un’opera ben calibrata in ogni sua parte, misurata ma non noiosa e soprattutto senza gangster che trascinano le parole con timbro siculo, è una vera e propria goduria per i sensi, soprattutto per le orecchie.
Le musiche accompagnano decorosamente le immagini amalgamandosi bene con un ritmo uniforme che lascia scorrere il film senza appesantimenti o improvvise accelerazioni. Su tutto si avverte la dolce mano della “medietas”: niente è sopra le righe e niente è al di sotto; il gusto di narrare non si abbandona a facili e banali dialoghi, l’agire dei personaggi è racchiuso in sequenze fatte di azioni più che di parole, ma queste, quando vengono pronunciate, pesano. Una scrittura che riprende alcuni aspetti utilizzati nel precedente “American Beauty”, film certamente più hollywoodiano, dal ritmo più sostenuto e una maggiore integrazione fra musica, immagini e sceneggiatura, ma vicino a Era mio padre nell’utilizzo psicologico delle scene. Il rapporto tra padre e figlio è quasi mai affrontato verbalmente, bensì attraverso ciò che Michael jr. vede fare a suo padre. Sparatorie, omicidi e sangue ribollono con frequenza, ma grazie ai rallenty e alle particolari inquadrature a catturare la nostra attenzione non è la violenza delle scene, ma la psicologia del ragazzo che quelle scene vede. Siamo sulla scia di American Beauty, quindi, trasportata in ambiente noir.
Peccato per la parte finale, che si libera della patina ‘anni 30 per aprirsi a colori vivi e luminosi, sciupata però da un retorico ed evitabile dialogo conclusivo tra padre e figlio, che, se nelle intenzioni del regista doveva firmare il significato del film, non fa altro invece che calpestare i piedi ad una scena eloquente di per se stessa. Piccola macchia che non fa certo ombra ad un ottimo lavoro.
Francesco Rivelli